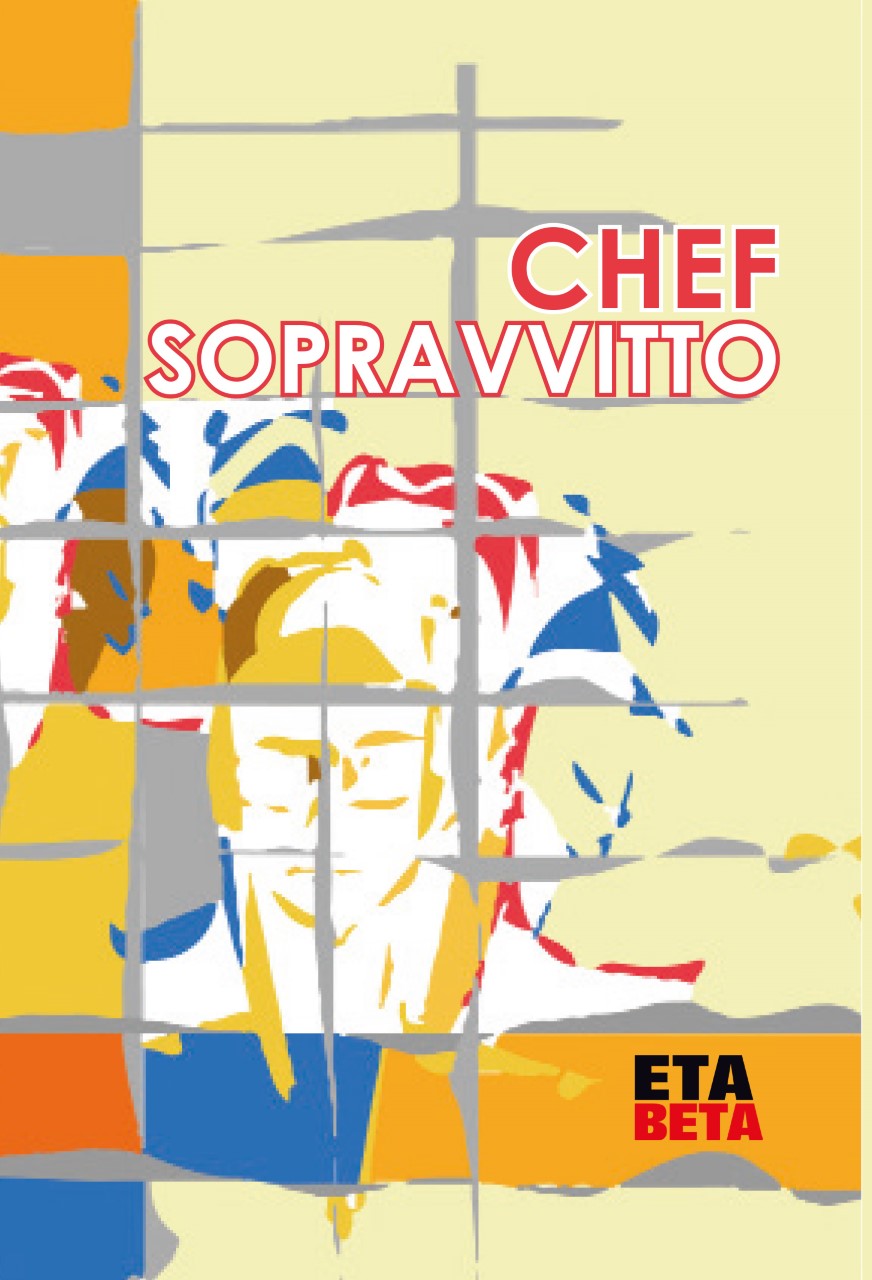Questo al di fuori della valutazione di qualsiasi lavoro si svolga o venga assegnato. Proprio perché il tipo di lavoro, la forma, l’orario, le condizioni stesse in cui si svolge o si possono svolgere sono dissimili.
In carcere, quando il lavoro è possibile averlo, diviene un lusso, un di più per il singolo che ne fruisce, perché permette di poter avere una certa autonomia economica, per quelle spese fluttuanti e necessarie di cui anche in carcere si ha necessità per disporre di un qualcosa che dia al soggetto una piccola gioia, che può essere l’acquisto di un genere o soddisfare particolari esigenze legate al fumo o altro. Il lavoro dunque pone in una posizione di vantaggio chi ne fruisca rispetto agli altri ristretti. Vantaggio dato dalla possibilità di spaziare fuori dell’ambito del reparto o della camera di pernottamento (oggi si definiscono così le celle), a seconda del lavoro assegnato, quindi il lavoro diviene un privilegio.
Inoltre, se si dovesse trattare di un lavoro più impegnativo di quello di routine, che potrebbe essere non riferito alle pulizie come inserviente o altro, ma qualificato, dove con tale aggettivo si possono indicare quei lavori più performanti (scrivani, addetti al servizio spesa, addetti alle cucine), che anche all’interno del carcere possono essere gratificanti, il lavoratore ricoprirebbe una funzione di utilità. Sì, perché i lavori all’interno del carcere non sono o non dovrebbero intendersi nell’accezione lavorativa di produzione, ma più in quella di attività rieducativa.
Poiché il nostro diritto prevede che il lavoro, qualunque sia, per dettame costituzionale deve essere retribuito, ecco dunque che tale funzione di conduzione e apporto lavorativo del carcere viene affidata al ristretto. Nel tempo, a seconda delle politiche del momento, nelle carceri vi erano aziende nazionali che, in accordo con il Ministero della Giustizia, usavano i ristretti per la produzione di merci varie, impiantando in aree apposite all’interno del carcere officine di lavoro che producevano, per esempio, interruttori elettrici oppure biciclette, dunque il lavoro è stato nel tempo, all’interno del circuito carcerario, uno strumento che ha avuto i suoi alti e bassi.
Questo può generare un fenomeno poco noto, ma a cui molti ristretti aspirano, quello di poter essere trasferiti in istituti ove il lavoro sia retribuito con maggiori introiti, dati da possibilità maggiori dovute a una funzione trattamentale più mirata al lavoro all’interno del carcere, dove le richieste superano la capacità di un collocamento lavorativo. Strano ma vero, la richiesta di poter accedere ad un lavoro all’interno di un carcere diviene calzante da parte del ristretto che voglia o creda di poter alleggerire l’afflizione detentiva in ozio.
Il paragone con un lavoro esterno diviene poi inimmaginabile. Poiché se è vero che per la conduzione di un istituto si necessitano inservienti per le varie mansioni di pulizie uffici e reparti, addetti alla cucina, addetti all’ufficio contabilità spesa, la maggior parte dei lavori è condensata in forma limitata, proprio per il compito che la mansione stessa richiede e per l’annichilimento della persona nello svolgerlo. In quanto se è vero che da un lato il lavoro interno permette uno spazio, una libertà di movimento, dall’altro la monotonia e la ripetitività dello stesso fanno sì che possa essere noioso e lo si faccia senza quella creatività che talune volte il lavoro, qualunque esso sia, dà come volontà e applicazione. Quindi, oltre al lavoro che deve essere possibile svolgere all’interno di un contesto detentivo, risulta valida anche la funzione dei corsi di formazione lavorativa, che possono permettere al soggetto di trovare una collocazione futura. Questi sono input di un qualcosa che può essere la risposta al futuro in virtù del rientro in un tessuto sociale sempre più marginale. Rimane la domanda della capacità poi del mercato del lavoro esterno di poter assorbire chi ha vissuto l’esperienza deviante del carcere, ma questa è una problematica più ampia.
R. P.